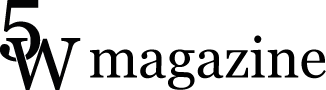Dopo l’ ultima replica di ogni spettacolo un camion s’accosta alla grande porta sul retro del Teatro; sopra il palcoscenico, estinto l’applauso finale, una schiera di tecnici con elmetti e scarpe antinfortunistiche comincia a smontare le scene, pezzo a pezzo, seguendo a ritroso lo schema seguito per montarle. Si deve far posto alla nuova opera, tutto va spostato con ordine, imballato e protetto; quel che appariva sotto le luci sorprendentemente vero ora rivela ossature nascoste, viti, corde, anelli d’ acciaio, pannelli costruiti su selve di assi e dove spesso noi del coro agiamo, su camminate e torri robuste, al posto di quelle appaiono ora intelaiature complesse di travi d’ acciaio. Sedie con tavoli foderati, oggetti di scena fino a ieri tra le mani di cantanti e attori ora fan parte d’ un preciso inventario, voci spuntate su carte e bolle di trasporto.
Illusioni di legno.
Dietro il Teatro la via stretta, mattoni rossi, vetri enormi scarabocchiati in basso e lampioni appannati, muri severi a guardia di cancelli e minimi scampoli di cortili improvvisi, concistoro di baristi fumatori e bidoni per bottiglie, poi librerie e ristoranti. Proprio in fondo alla via, a volte quasi tratteggiata nella foschia, fila interrotta di luci in alto, una collina o forse fari di nave nascosta. Più avanti la vita rallenta, inghiottita dalla strettoia, da curve attorno alle transenne, telecamere agli angoli del palazzo, curiose antenne o anonimi globi di vetro lucente.
Un sordo mugghiare di passi ier sera, scolpito catrame dai tacchi, signore in arrivo, quasi ancora il caffè in gola, cipria dorata, capelli in ordine; corron contente alle porte d’ ingresso, biglietti e chiacchiere dietro quei vetri mentre ancor più lontano, fuori dai bar della zona, avventori dell’arte e curiosi in cappello sorridono, stringono mani, ricordano nomi, dicono frasi di corsa in cellulari ammutoliti. Quando il sipario si stringe per l’ultima volta dopo gli applausi, fretta d’uscire all’aperto a fumare e scie rosse di fari, rapide corse a pensare nel fresco serale al domani, presi alcuni nell’anima da musica e voci, tenendo il ricordo in disparte.
Ora che l’ultimo applauso è memoria sotto la torre di scena, dal grande portone sul retro sfilano pezzi smontati di balaustra grigia, teli enormi e chiari del fondale già arrotolati, piegati, pesanti come tronchi con linfa e corde sulla strada, un lampadario enorme di vetro, avvolto con cura tra carta e coperte. Con ordine attento si sgombera il sogno di ieri, immobili oggetti per l’arte, illusioni di legno con resine indurite, colori e listoni dipinti, sostegni di ferro e travi, pannelli colorati, chiodi, catene, tiranti e cacciaviti, mari e montagne smontati come giochi per ragazzi. Dalla strada rumori sui vetri graffiati, tra le maglie di scena e costumi, velluti e sudore. Dentro il palco senza scene, privo di oggetti e di ombre, le sedie scomparse, specchi, tavoli, tappeti rapiti, guanti e braccia che spostano e creano spazio totale, sotto grate altissime con riflettori spenti, il cemento scuro ai lati del sipario chiuso, vento con polvere chiara all’inizio delle scale, sembra che tutto riparta daccapo, che possa apparire e pulsare di nuovo, che abbia soltanto bisogno di pause, come un respiro. Palco senza oggetti, la storia si ferma e non trattenuta si dilata come deserto senza dune. Dalle poltrone di velluto rosso guardo il mondo dietro il sipario, quel legno nero un po’ consunto da passi e stridore d’ acciaio.
Fuori, tranquilli operai nelle tute, pausa caffè tra sigarette e argani: parlano seduti vicino al grande portone del cambio di scene, tutto il magico mondo di ieri, giochi smontati e visioni di scenografo impilate e spinte nel camion che attende nella via stretta dietro il Teatro. Tutto ancora e di nuovo riparte dopo l’applauso dell’ultima recita.
Immagine di Vincent Teriaca