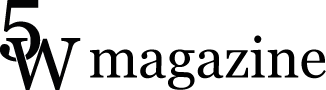Dimmi come vesti e ti dirò chi sei. Raccontando della cerimonia romana di investitura dei ministri componenti il nuovo Governo, riferendosi all’abbigliamento indossato per l’occasione da un parlamentare, recentemente un giornalista della carta stampata ha usato una espressione che nel nostro parlare quotidiano sta scomparendo: in ghingheri.
Ghingheri – questa parola esiste solo dalla fine dell’Ottocento – è voce onomatopeica d’uso familiare, scherzoso, che probabilmente deriva da agghindare o forse da cingolo, parola quest’ultima di area pistoiese, riferita a cinture, nastri, e anche a catene per muoversi su terreni accidentati: i cingolati delle forze armate, dei trattori agricoli e delle macchine movimento terra.
Nel nostro caso la parola in questione è quello che oggi chiamiamo ‘dress code’, il codice d’abbigliamento richiesto, la specifica indicazione di un preciso abbigliamento per l’occasione è innanzi tutto una forma di rispetto verso il prossimo, e un mezzo di comunicazione non verbale, come spiega Ugo Volli, professore di filosofia del linguaggio: «Nel caso dell’abbigliamento, la norma regola in primo luogo la scelta degli indumenti […] deve considerare il loro accoppiamento, il loro modo di fare abito e di “intonarsi” al contesto». Questa è la ragione per cui soprattutto gli abiti scuri “comunicano” potere, formalità, classe, raffinatezza, eleganza e credibilità. Come tutte, anche questa norma ovviamente può essere infranta. Ma solo occasionalmente. Mettersi in ghingheri vuol dire avere un proprio stile, essere col proprio abbigliamento in armonia con il contesto, comunicare ciò che siamo.